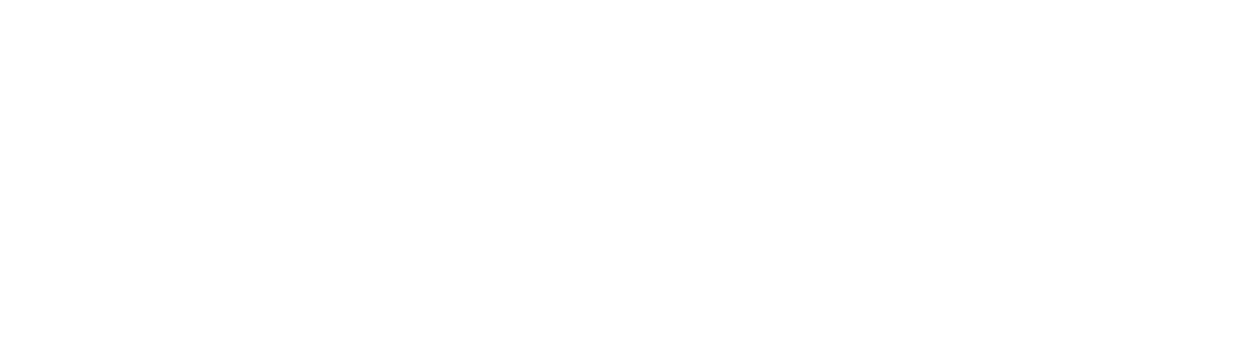Una famiglia e la sua storia
Un’estate da ricordare
Paternopoli, estate 1967. Ore 4:30 del mattino. “Genero’, muoviti. C’è da dare il rame alle viti”.
Generoso è mio padre, allora dodicenne, che ancora intontito dal brusco risveglio si precipita in cucina. Ad attenderlo una fetta di pane con una spolverata di zucchero e un bicchiere di latte fresco. I grandi hanno già provveduto alla colazione: pane e peperoni fritti con i pomodorini gialli.
A svegliare mio padre è stato suo nonno, Generoso. Il capofamiglia che si appresta a dirigere i lavori nel vigneto.
All’epoca i trattamenti contro le classiche malattie della vite erano piuttosto semplici. Il verderame in pietra era chiuso in un sacco di iuta ed immerso in acqua per essere disciolto. Successivamente si procedeva a miscelare il rame con la calce. Infine, al preparato veniva aggiunta acqua.
La pratica veniva svolta con una pompa di rame a spalla, della capacità di circa 20 litri. Era un lavoro massacrante perché bisognava portarsi dietro il peso della pompa per ore e ore affinché tutte le viti potessero essere raggiunte. Il lavoro più duro spettava ai miei nonni e ai miei zii, mentre il mio bisnonno preparava il “medicamento”. Per la prima volta, anche mio padre, che era il maggiore dei nipoti, partecipò ai lavori: tirava su l’acqua dal pozzo.
Il pozzo, tuttora in funzione, era stato scavato a mano intorno agli anni ’30 ed era stato nonno Generoso ad individuarne la falda. Lui era un abilissimo rabdomante. Riusciva a trovare le vene d’acqua nel terreno con l’utilizzo di un ramoscello di ulivo. Posizionava il ramoscello ad arco ben saldo tra le sue mani e non appena transitava su di una fonte acquifera il ramoscello cominciava ad alzarsi ed in base alla forza con la quale avveniva il sollevamento era in grado di quantificarne la portata e la profondità.
La danza dell’acino
Le giornate d’estate erano molto intense e un po’ tutte uguali a sé stesse. La cura delle viti proseguiva sempre a rilento e gli effetti della protezione non duravano più di una settimana. Non c’è da stupirsi, allora, se l’arrivo dell’autunno era visto come una benedizione. Solitamente l’ultimo trattamento coincideva con la festa del Santo Salvatore, la terza domenica di settembre. La contrada si vestiva a festa e veniva attraversata in lungo e in largo da una piccola processione. Ho sempre pensato che quel giorno sia stato scelto proprio per segnalare la fine dalle fatiche estive e l’inizio del periodo della vendemmia. Ultimo sforzo prima del meritato riposo invernale.
Durante la vendemmia nonno Giuseppe diventava il protagonista assoluto. Quando l’uva arrivava in cantina, lui si arrotolava i pantaloni e saliva gli incerti pioli della scaletta in legno adagiata lungo uno dei tini. Agli occhi di un bambino come me era quello il momento che racchiudeva tutta la magia: l’inizio della pigiatura dell’uva. La danza leggiadra di mio nonno era ritmica, possente, incessante. Ogni volta speravo non finisse mai. E vederlo, esausto, quando ridiscendeva la scaletta era come vedere una rockstar scendere dal palco dopo un concerto: la pelle madida, gli occhi stanchi, ma un sorriso che non dimenticherò mai.
La cantina la ricordo bene. Posso ancora sentirne gli odori. Il profumo dei formaggi di capra posti sui graticci o dei salami appesi ai ganci uncinati di cui era disseminato il soffitto.
Il senso di fresco che ti avvolgeva quando ci entravi e il silenzio monastico che ti accompagnava per tutto il tempo.
La luce era poca ma non si faceva fatica a scorgere i grandi tini in legno di castagno impiegati per vinificare l’aglianico e le botti per conservare il vino. Accanto alle botti si ergevano degli scaffali in legno di pino che venivano buoni per riporci qualunque cosa.
Il pavimento era un mosaico di pietre poste direttamente sul terreno. Era molto irregolare e sempre umido.
Il cigno nero che non ti aspetti
Il vino che si produceva veniva venduto sfuso. Il prezzo solitamente lo faceva mia nonna: 300 lire al litro per il “novello”; 500 lire per quello che era rimasto a riposare qualche mese nella botte. Per lei il commercio è sempre stato una questione di famiglia. Già suo padre possedeva un frantoio, di quelli con le grandi macine di pietra che venivano azionate dai buoi attraverso un girotondo infinito.
Nonna Talina era anche la titolare di una piccola drogheria e tabaccheria. Della tabaccheria conservo solo l’insegna in ferro. Della drogheria, invece, serbo un ricordo molto più profondo ed autentico: caramelle gratis ad ogni ora del giorno e ghiaccioli all’amarena per tutta l’estate.
La vita contadina della mia famiglia sembrava una istantanea destinata a rimanere immutabile per sempre. Ed invece nel 1980 un terremoto devastò l’Irpinia. Interi paesi furono inghiottiti ed anche la quotidianità conosciuta fino ad allora fu messa a repentaglio. La grande casa paterna fu pesantemente danneggiata. Anche la cantina fu compromessa. Ma il cigno nero che non ti aspetti non smosse solamente la terra bensì creò delle fratture profonde anche nelle coscienze, nel modo di pensare, delle persone. Poco più di un minuto che mutò per sempre questi luoghi.
Il futuro sembrò allora improvvisamente più fragile. Avere un lavoro stabile come impiegato sembrava un’aspirazione desiderabile rispetto all’incertezza di una vita spesa nei campi. Tra i tanti giovani dell’epoca, fu questa la strada intrapresa anche da mio padre e mio zio.
Di fronte alla nuova realtà, le ambizioni dei nonni di mettere su una cantina più moderna si infransero clamorosamente. Tuttavia nonno Giuseppe, pur tra mille sacrifici, continuò a condurre i vigneti conferendo ad altri la maggior parte delle uve. Il vino continuò a produrlo nella vecchia cantina, ma solamente per sé. Oramai non danzava più per pigiare l’uva ma non perse mai il suo sorriso. Rimase fedele alla sua natura contadina fino alla fine dei suoi giorni.
Ricominciamo da dove avevamo lasciato
Con l’arrivo del nuovo millennio la cura dei vigneti di famiglia è stato un onere che è gravato su mio padre.
Le viti all’epoca erano allevate secondo il metodo tradizionale della “tennecchia avellinese” ed era arduo occuparsene in modo regolare e puntuale per chi oramai da anni aveva riposto nel cassetto i pantaloni alla zuava e la camicia a quadri. Tuttavia il senso del dovere di mio padre soverchiò l’ipotesi di abbandonare tutto. Ed allora nacque l’idea di rinnovare i vigneti, convertendoli ad un allevamento più moderno – come la controspalliera – che fosse in grado di favorire una gestione più rapida attraverso la meccanizzazione di molte operazioni che prima erano condotte manualmente.
Generoso, mio padre, è sempre stato attratto dalle novità, da tutto ciò che porta con sé la parola progresso. Ed è sicuramente grazie al suo pragmatismo che la tradizione e la cultura della vigna non è andata perduta nella nostra famiglia.
Tuttavia, nonostante gli sforzi profusi “l’affaire vigna” rimaneva confinato alla vendita dell’uva. E col passare delle annate è stato sempre più evidente quanto fosse frustrante consegnare ad altri il frutto di un anno di tribolazioni e di passione. Altri che, probabilmente, non avrebbe trattato le nostre uve come esse meritavano. Allora, con un pizzico di insana follia, abbiamo deciso di ricominciare da dove avevamo lasciato. Abbiamo ripreso in mano tutte le vecchie attrezzature dei nonni e abbiamo ripreso a vinificare.
La nostra storia probabilmente assomiglia a tante altre storie. Ma prima di parlarvi di quello che facciamo oggi ci sembrava doveroso parlarvi di quello che è stato fatto fino a ieri. Perché, si sa, i contadini sono schietti come i vecchi amici.